Non è che se leggi i classici sei più intelligente
Fosse così semplice, il mondo sarebbe un posto migliore
Mi ricordo la prima volta che ho ascoltato Madame Bovary. Non l’ho letto, no, l’ho ascoltato con mio padre, fedele adepto di Radio 3. Avevo circa otto anni, durante quei pomeriggi in cui mi veniva a prendere da mia nonna con la sua Mégane Scénic, che puzzava sempre di vestiti bagnati.
Quella probabilmente è stata l’unica volta in cui ho amato un classico senza forzarmi a farlo.
A undici anni ho preso Delitto e Castigo di Dostoevskij da una bancarella dell’usato e ho pensato fosse la cosa più barbosa del mondo (e il libro più sporco mai avuto tra le mani). A tredici ho voluto provare Émile Zola, ma diciamolo: cosa poteva mai dirmi Germinal quando il mio unico pensiero era il dramma adolescenziale del primo ciclo mestruale? E del ragazzo che non mi si filava, e non l’avrebbe mai fatto.
E così la storia è andata avanti. Voltaire, Dumas, Austen. Mi sono forzata a leggere i classici per sentirmi diversa dalle ragazze della mia età. (Lo ero già, non so perché volessi accentuare la mia stranezza. Forse perché se gli adolescenti non mi accettavano, lo avrebbero fatto gli adulti?) Finché non ne ho avuto la nausea.
E ho capito una cosa banale ma non scontata: leggere un libro e capirlo sono due cose diverse. E molta gente non lo sa fare.
Il mito del lettore di classici
Non so bene chi abbia diffuso questa leggenda metropolitana del lettore di classici come ultimo detentore della sapienza umana. Fatto sta che, quando vado a casa della mia amica e vedo la sua libreria piena di Adelphi, così perfetti, interessanti e radical—oltre al fatto che ha una casa di proprietà, cosa che io non avrò mai—penso sempre che ne sappia molto più di me. Io, con i miei libri sarcastici scritti per lo più da donne trentenni con la prescrizione per lo Xanax.
Ma perché? Il peso di un libro è proporzionale all’intelligenza? Chi ce lo ha detto? E soprattutto, se lo hai letto ma non lo hai capito, vale comunque?
Maryanne Wolf nel suo libro "Proust and the Squid: The Story and Science of the Reading Brain" sottolinea che il cervello umano non è geneticamente predisposto per la lettura; ogni testo complesso stimola la neuroplasticità, rafforzando le connessioni sinaptiche e favorendo un’evoluzione cognitiva adattativa.
Ma, aggiungo, solo se il lettore è in grado di decodificarli. In caso contrario, non è cultura: è un badge di intellectual flexing. (Non sono D’annunzio, per cui gli inglesismi li uso).
Ecco il vero problema: spesso non leggiamo i classici perché vogliamo, ma perché ci sentiamo obbligati.
Ma perché la gente si sente in colpa se non li legge?
L’altro giorno, mentre guardavo la pila di classici a prendere polvere, mi è tornata in mente una frase di Pierre Bourdieu: la cultura è un codice sociale. È una cosa che tutti sanno, anche se nessuno lo ammette apertamente.
Leggere i classici è un modo per dimostrare appartenenza a una certa élite intellettuale, un gusto letterario plasmato dalla classe di appartenenza. In altre parole, a volte ci si sente costretti a leggere Tolstoj non per puro piacere, ma per dimostrare di essere parte del "club giusto".
Forse è per questo che le persone che leggono narrativa leggera si affrettano a precisare che: "sì, però ho letto Virginia Woolf, eh!". Come se questo rafforzasse la propria credibilità di lettore.
È sempre stato così. Già, secondo un articolo dell’ Internazionale, nel II secolo d.C., Luciano di Samosata prendeva in giro i ricchi ignoranti che ostentavano libri senza averli mai letti, dicendo:
"La scimmia è sempre scimmia, anche se ostenta un distintivo d’oro”.
L’intelligenza non è solo cultura libresca
La storia della scimmia ha piantato il suo seme. Dopotutto, è l’unica spiegazione che mi do per quelle persone che millantano grandi letture e poi mancano di empatia, solidarietà, compassione o un minimo di pensiero critico flessibile.
Come penso sappiano tutti, e in caso contrario ce lo dice lo psicologo Howard Gardner, esiste la teoria delle intelligenze multiple, secondo cui l’intelligenza non è un blocco unico, ma si manifesta in almeno otto forme, tra cui:
Linguistica-verbale (tipica dei lettori accaniti - non io, però)
Logico-matematica (analisi e ragionamento critico)
Interpersonale (empatia e capacità di leggere gli altri)
Intrapersonale (autoconsapevolezza, introspezione)
Incredibile ma vero: uno può non aver mai letto Anna Karenina, ma avere una capacità di osservazione e comprensione della realtà maggiore di chi lo ha fatto. E lo dimostra la storia: intellettuali ritenuti brillanti hanno sostenuto regimi totalitari o ideologie oppressive.
Classici e snobismo culturale
Da un lato abbiamo quelli che leggono i classici per poter dire di averli letti. Dall’altro, quelli che venerano i classici e schifano la letteratura leggera, se non qualche testo sperimentale tipo Lingua Madre, la collana Adelphi, testi filosofici. Qualsiasi cosa che sa di marketing viene allontanata con l’acqua santa.
Inutile dire che solitamente questi ultimi sono maschi, abbastanza giovani, ma vestiti tipo cosplayer di Hugh Grant in Notting Hill, su TikTok.
Su il mio BookTok, questa tipologia di narrazione radical è in contrapposizione all’altra, quello dei lettori romantasy/romance/fantasy, sfoggiando letture "alte", criticando la letteratura contemporanea, evitando quella di genere (a volte hanno pure ragione, ma è il modo e tono di voce a darmi fastidio).
Tipo sto tizio che mi appare che pare Il Nero di Romanzo criminale.
Lo snobismo letterario maschile è una tendenza che è più difficile da smacchiare del mascara waterproof. Si adatta ai tempi mantenendo intatta la sua essenza: l'uso della letteratura come strumento di distinzione sociale e oppressione. Per dimostrare di non avere tempo da perdere con librucci, perché sono uomini, sanno ragionare e hanno da fare—tipo mandare a puttane il mondo.
Perché leggiamo i classici, allora?
Okay, quindi abbiamo demolito il mito: i classici non ti rendono più intelligente.
Esiste chi li legge per piacere, non li ho citati perché mi pare ovvio, ma lo scrivo così dormiamo tranquilli.
Ma allora perché leggerli?
Perché alcuni parlano ancora al presente.
1984 è più attuale che mai, e Orwell ci ha spiegato la manipolazione della realtà meglio di qualsiasi talk show politico.Perché espandono il nostro pensiero.
Ma solo se siamo pronti a leggerli. A undici anni Dostoevskij era una tortura, ma oggi potrebbe avere tutto un altro sapore.Perché non è vero che o leggi classici o niente.
Leggere Orgoglio e Pregiudizio non ti impedisce di apprezzare un bel romanzo contemporaneo. Non è un aut aut.
Leggere classici non è obbligatorio
Leggere i classici non è un passaggio obbligato per sviluppare uno spirito critico. L’intelligenza si costruisce in tanti modi: esperienze, confronto, osservazione.
Se ami i classici, leggili. Se non ti interessano, non sentirti in colpa. E soprattutto, non lasciarti intimidire da chi pensa che la cultura sia esclusiva o che il tuo genere letterario preferito sia carta da cesso. Perché probabilmente la personalità di chi lo dice lo è.
Alla prossima settimana!





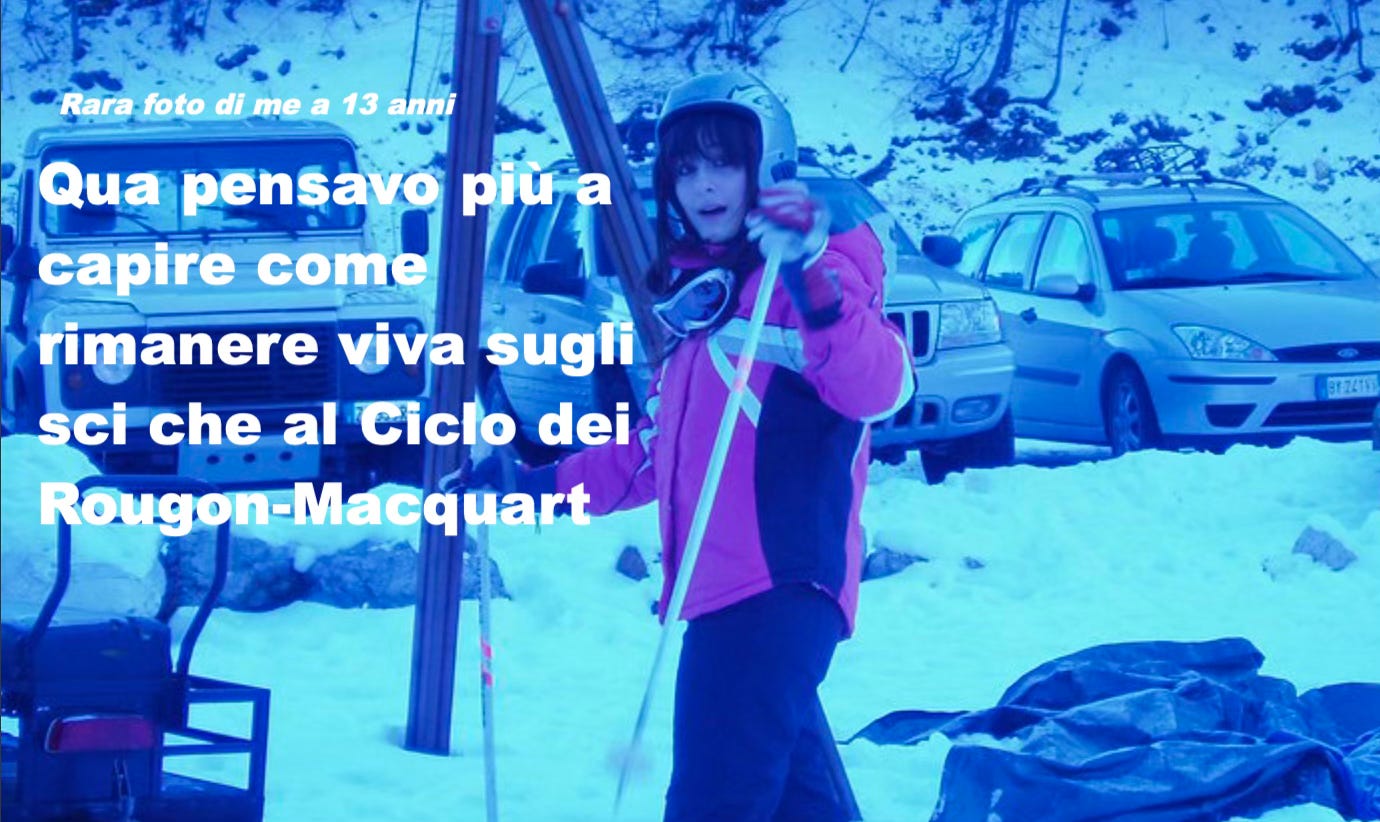




Io Delitto e Castigo l’ho trovato noioso anche a 40 anni, eppure penso di averlo capito 😅… Ci sono classici e classici, alcuni vorrei poterli dimenticare per rileggerli, ma credo che molti invece dovrebbero cadere dal piedistallo su cui sono stati messi, perché negli ultimi 100/200 anni ne sono state scritte di cose buone, e nn proprio tutti sono invecchiati bene…
Io penso che leggendo si possa ampliare il vocabolario, allenare l’immaginazione, cambiare punto di vista, accrescere le proprie conoscenze e la propria cultura… ma intelligenti si nasce, non si diventa. Nemmeno leggendo i classici. ❤️